Due popoli, una guerra, nessuna pace:
il dramma della Palestina
di Bianca Olivieri
Il 23
settembre 2025, nell’Aula Magna del Liceo Calasanzio, si è tenuta una conferenza sul tema
“Palestina, Diritti Umani, Pace”, con la partecipazione dell’associazione
israeliana “Ta’ayush” (traduzione di “Vivere Insieme”), organizzazione
israeliana attiva nella difesa dei Diritti dei Palestinesi della Cisgiordania. Era
presente all’incontro anche un referente di “Operazione Colomba”, movimento
pacifista dell'Associazione "comunità Papa Giovanni XXIII".
Un membro
dell’associazione è venuto a raccontare in prima persona, attraverso immagini e
filmati, l’evoluzione della situazione nei territori occupati. Le sue parole
hanno offerto uno sguardo umano e concreto su un conflitto che spesso
conosciamo solo attraverso i telegiornali.
Per
capire l’attuale crisi bisogna fare un passo indietro: alla fine della Prima
guerra mondiale, molti ebrei emigrarono in Palestina sognando un luogo sicuro
dove vivere dopo secoli di persecuzioni, culminate con la Shoah. Nel 1947, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite propose
di dividere la Palestina in due Stati: uno ebraico e uno arabo. Gli ebrei
accettarono, gli arabi no, giudicando il piano ingiusto.
L’anno
seguente, con la nascita di Israele, esplose la Guerra
arabo-israeliana del 1948. Israele vinse e occupò gran parte dei territori arabi. Per
centinaia di migliaia di palestinesi questo significò espulsione e perdita
della propria casa: un evento che chiamano Nakba, cioè “catastrofe”.
La Cisgiordania è ancora oggi divisa
secondo gli Accordi
di Oslo del
1993: una parte sotto il controllo palestinese, una parte a controllo misto e
una parte, circa il 60% , sotto controllo israeliano.
Nel
tempo, Israele ha costruito in territorio palestinese centinaia di insediamenti
abitati da coloni israeliani. Questi insediamenti sono considerati illegali
dalla comunità internazionale, ma continuano ad espandersi, riducendo gli spazi
per i palestinesi: molte città palestinesi vivono ogni giorno sotto sorveglianza
militare, tra check-point e posti di blocco che spesso rimangono chiusi per
ore. Questo significa non poter andare a scuola, al lavoro o semplicemente
muoversi liberamente.
Dal 7
ottobre 2023, la violenza è aumentata ancora: dopo l’attacco di Hamas, in cui furono uccisi e
presi in ostaggio circa 1500 israeliani, Israele ha lanciato un attacco contro
la Striscia
di Gaza,
controllata da Hamas. I bombardamenti hanno provocato una gravissima crisi
umanitaria. Anche in Cisgiordania la situazione è peggiorata: arresti e
violenze si sono moltiplicati, alimentando la paura che il conflitto si estenda
anche lì.
Il
testimone ha mostrato video scioccanti: coloni armati che infastidiscono
pastori palestinesi, distruggono cisterne d’acqua e intimidiscono le persone,
spesso senza subire conseguenze. I palestinesi, ha spiegato, non reagiscono
perché rischierebbero l’arresto o peggio.
Gli
studenti presenti hanno posto molte domande; qualcuno ha anche chiesto se la Giornata
della Memoria potesse
cambiare significato alla luce del conflitto attuale. L’ospite ha risposto che
quella celebrazione non deve e non può cambiare: si tratta di eventi storici
distinti. Tuttavia, ha sottolineato come a volte venga usata per giustificare
certe azioni dello Stato israeliano.
Un’altra
domanda riguardava i coloni: “Perché non vengono puniti?”. Un video mostrava il
ministro delle Finanze israeliano mentre donava veicoli ai coloni, strumenti
poi usati per oltraggiare i palestinesi. Un messaggio chiaro: invece di essere
sanzionati, spesso ricevono supporto.
Il cuore
del conflitto rimane la terra. Due popoli rivendicano lo stesso luogo come
patria. Gli israeliani cercano sicurezza e riconoscimento, i palestinesi
invece, chiedono libertà e dignità, in mezzo a ciò ci sono però muri,
check-point, paura e dolore. La Cisgiordania è diventata il simbolo più
evidente di questa ferita: un luogo dove ogni giorno si decide il destino di
due popoli che, in fondo, desiderano la stessa cosa: vivere in pace nella
propria terra.
Bianca Olivieri

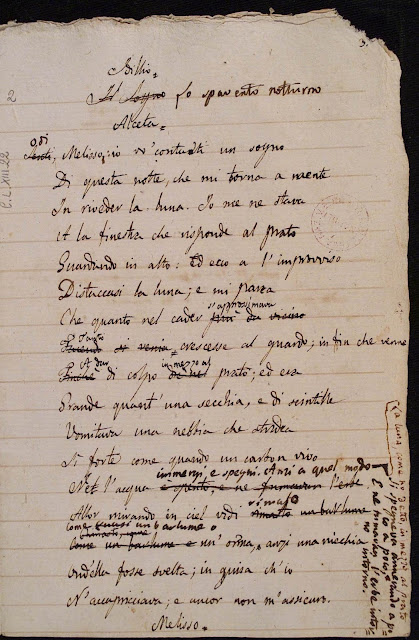

Commenti